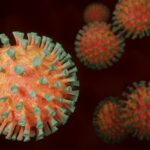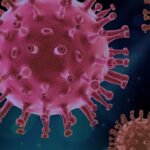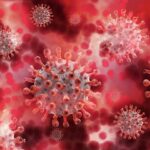Coronavirus: dal dovere della paura al diritto della responsabilità
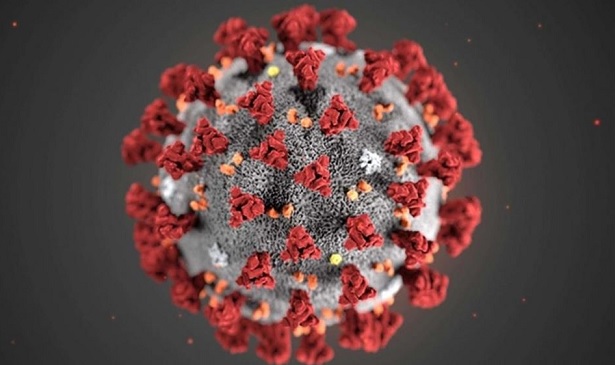
“Qui chi non terrorizza, si ammala di terrore” scriveva Fabrizio De Andrè nel 1973, ma avrebbe potuto scriverli oggi, questi versi, in una canzone sul Coronavirus.
L’assalto alla stazione di Milano è la fotografia sconcertante di un paese in preda al panico: biglietterie prese d’assalto, scale mobili ai limiti del collasso, vagoni ferroviari costipati come treni in fuga da un campo di concentramento. Le comunicazioni tardive del Governo sulle nuove misure relative allo spostamento delle persone nei territori assediati dal virus hanno piegato alla psicosi definitiva gli inurbati del Sud Italia nel loro compulsivo ritorno al paese natale. In una società tecnologica come è la nostra, dove tutto è funzionalmente irreggimentato e statisticamente prevedibile, l’imprevisto, in quanto anche non pensato, è causa del più profondo terrore.
Ciò nonostante, chi dovesse pensare che nelle crisi della storia degli uomini il ricorso alla razionalità sia il solo saggio rimedio, sarebbe nel torto. Se intende reagire, essa deve nutrirsi di emozione. Già Eschilo, nell’antica Grecia, insegnava che la passione e la sofferenza sono fonti di conoscenza. Con le immagini della stazione di Milano, abbiamo assistito a scene di paura o di panico? Se le reazioni si fanno incontrollate, la capacità di analisi razionale viene meno, le funzioni riflessive sono sostituite da una serie di comportamenti automatici che nuocciono più del pericolo stesso, allora siamo di fronte al panico, che enfatizza in modo eccessivo e patologico gli atti umani sino a renderli inutili e dannosi. Al coraggio di sottrarsi al panico si dovrebbe piuttosto rivendicare il dovere della paura, di quel sentimento nobile che con l’intelligenza razionale dà il giusto rimedio alle cose. Piuttosto che provare vergogna per la paura, quasi che fosse una implicita dichiarazione di inadeguatezza dello stare al mondo, la si dovrebbe partecipare con orgoglio e renderla un sentimento di comunità. Tutto coloro i quali alla stazione di Milano hanno ceduto al panico, fino al giorno prima non avevano paura; l’avessero avuta, non sarebbero stati così irresponsabili da saltare sul primo treno in corsa.
E nelle settimane passate avremmo dovuto nutrire un maggiore sentimento di responsabilità per il nostro futuro, e se in luogo di una cinica noncuranza – o del ridicolo disappunto di chi si angoscia per un aperitivo impossibile o per una seduta di pilates prorogata – che per contrappasso porta dritta al panico avessimo avuto paura, oggi staremmo meglio. Che abbiamo paura dobbiamo dirlo: una paura che non paralizza l’azione e comprende le cose, che scopre il disagio e lo tollera, che ammette l’errore e lo corregge. Proprio di questo scrive il celebre filosofo tedesco Hans Jonas nel suo libro “Il principio di responsabilità”, evocando addirittura il dovere della paura quando sostiene che «diventa necessario il fiuto di un’euristica della paura che non si limiti a scoprire e raffigurare il nuovo oggetto, ma renda noto il particolare interesse etico che ne risulta.» Alla luce del principio di responsabilità, più ancora delle immagini di Milano sconcertano gli assembramenti umani che i fuggiti dalla peste manzoniana concorrono a creare, incuranti del rischio per la salute degli altri nelle città d’origine cui essi sono ritornati, prevalendo con incauto cinismo il principio egoistico sul bene collettivo. Mentre i social media ci incantano con la danza macabra dell’andamento epidemico, si compie la parabola dalla fiducia nella quarantena volontaria alla certificazione dell’imbecillità di massa: la sconfitta senza appello del libero arbitrio.
Ora che la zona rossa è stata estesa a tutta Italia e le prescrizioni di comportamento si compiono giustamente limitando la libertà personale, possiamo riflettere sugli atti di idiotissima millanteria che qualcuno ha affidato ad alcuni video che sono circolati in queste ultime 48, e da qui utilizzare i quindici giorni di isolamento obbligato per riflettere sul male che – dopo il Coronavirus – appare come il più subdolo e insolente: l’analfabetismo di ritorno. In 15 giorni si può far poco, ma è il tempo giusto per cominciare da dove avremmo dovuto iniziare tutti. Forse un libro non salva la vita, ma la rende di certo meno inutile.
Beniamino Biondi